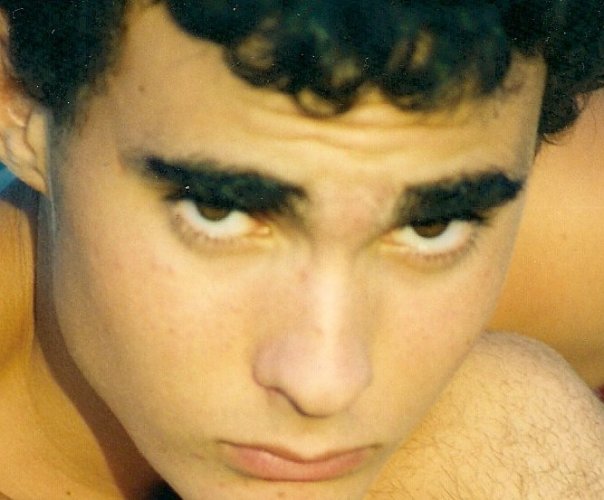da www.italia2013.org
Ci puoi arrivare in diversi modi: per esempio, da un lavoro dipendente (in una delle sue tante varianti) che perdi da un giorno all’altro, o da una libera professione che, dopo anni di crisi via via più pesante, alla fine si ferma completamente. Comunque ci arrivi, la situazione è la stessa: non hai un lavoro e non guadagni un centesimo. Se hai il vantaggio di un po’ di soldi da parte, cominci con qualche rinuncia, tagli le spese superflue e ti cerchi un altro lavoro. Ma non lo trovi. Dopo un po’, anche quel vantaggio iniziale è bruciato. A questo punto, quale che sia il modo in cui ci sei arrivata/o, hai accumulato bollette da pagare, l’affitto o il mutuo non riesci a pagarlo neanche se fai i salti mortali, non entri da mesi in un negozio che non sia un supermercato, e anche lì devi fare molta attenzione.Durante questa discesa agli inferi, vedi la tua vita stravolgersi giorno dopo giorno e, giorno dopo giorno, hai l’impressione che ti sfugga dalle mani. Non hai molte opzioni, e quelle che hai dipendono dalle tue relazioni familiari, affettive, sentimentali. Forse hai un partner, una famiglia o degli amici che possono garantirti chi un tetto sulla testa, chi il pranzo, chi un piccolo prestito a fondo perduto. Sai che non morirai di fame e di stenti, ma hai perso la tua indipendenza. Se invece questa fortuna non ce l’hai, se non hai nessuno che possa sostenerti materialmente, la tua stessa sopravvivenza fisica è a rischio.
Questa è la crisi, per chi la vive nella sua forma più estrema. È una prova durissima da affrontare, simile per certi aspetti a un lutto o a una malattia grave. Difficile, in queste circostanze, non provare autentica disperazione. La disperazione – si sa – può attivare risorse impensate, incoraggiare la ricerca di soluzioni nuove, generare forza. Ma il vissuto di chi subisce i colpi della crisi non è fatto soltanto di una realtà materiale segnata da mancanza di soldi, difficoltà a trovare un lavoro, relazioni personali più o meno soccorrevoli. Anche la persona più povera e sola è immersa completamente nel racconto che della crisi viene fatto – dai media, dalla politica, dal discorso pubblico in generale.
Ed è un racconto insidioso come una palude, che si insinua nel vissuto insieme alle ambiguità e ai pericoli nascosti che porta con sé, condizionando così l’immagine di se stessi, delle proprie risorse e del proprio valore. Questo racconto ripete instancabilmente (e neanche tanto tra le righe) affermazioni che oramai suonano come ovvietà: “Se non hai un lavoro, non hai un posto nella società, non sei niente, la tua vita non ha senso.” “Se non hai soldi da spendere, non sei nessuno, sei ai margini della società, la tua vita non ha senso.” “Se non sei in grado di mantenere te stesso, la tua famiglia, i tuoi dipendenti, sei un fallito, hai perso la tua dignità, la tua vita non ha senso.”
Sono affermazioni del tutto false, ovviamente, perché cose come la dignità e il senso della vita hanno poco a che fare con il denaro di cui si dispone o con la posizione che si occupa. Ma, un po’ per la frequenza con cui vengono ripetute e un po’ per l’assenza di un racconto alternativo, riescono a farsi strada nel vissuto di chi della crisi sta subendo i colpi più duri. L’intima convinzione che il senso della tua vita dipenda da un lavoro stabile, dal denaro, dalla capacità di provvedere ai bisogni materiali tuoi e di chi dipende da te, ti rende fragile, profondamente vulnerabile nei confronti dei rovesci della vita, in particolare quelli causati dalla crisi economica. E, peggio ancora, ti fa sentire del tutto impotente.
Se la tua vita dipende da processi macroeconomici, da manovre governative, dall’altalena delle borse e dello spread, tu sei come di fronte a uno tsunami: se hai l’energia per farlo, puoi tentare di fuggire lontano, altrimenti non ti resta che abbandonarti all’ondata sperando di uscirne viva/o. Infine, questa implicita adesione al racconto della crisi ti fa sentire completamente sola/o. Se il senso della tua vita dipende dal trovare un posto fisso o un credito da parte delle banche, i legami affettivi, le amicizie, le relazioni liberamente scelte non contano più niente; al più, sono i testimoni (anch’essi impotenti, e talvolta colpevolizzanti pur senza volerlo) del tuo dramma individuale – un dramma che si svolge nella più totale solitudine.
È qui, su questo senso di fragilità, di impotenza, di solitudine, sull’ansia che tutto ciò può scatenare, che la disperazione sprofonda nella depressione. È qui, in questo vissuto che ha interiorizzato un racconto della crisi secondo il quale il senso della tua vita dipende dal lavoro retribuito, dalle capacità di reddito, dal denaro di cui disponi, che inizia la rinuncia ai progetti, ai sogni e ai desideri; è qui che inizia la dissoluzione delle energie vitali. Tant’è – inevitabile pensarlo a questo punto – che c’è chi decide di togliersi la vita.
Quello dei cosiddetti “suicidi per crisi” è un argomento difficile e doloroso. Il rispetto verso chi ha fatto questa scelta estrema suggerisce cautela e delicatezza, ma l’amore per chi è vivo e disperato impone una riflessione, e un cambio di passo. Prima di tutto, un dato: secondo una ricerca Istat riportata dal Daily Wired , non è vero che con la crisi sono aumentati i suicidi, e nemmeno che sono aumentati i suicidi per “motivi economici”. L’enfasi data dai media e dal discorso pubblico ai casi di suicidio per motivi economici, quindi, non è motivata da dati oggettivi.
Eppure, sembra che il racconto della crisi non possa farne a meno: dal deplorevole sciacallaggio di chi tenta di strumentalizzare politicamente queste morti, alla cronaca solidale e partecipe del disagio sociale indotto dalla crisi, un suicida sotto i riflettori c’è sempre. Alla faccia del fattore emulazione, ben noto a chi si sia occupato di suicidio come fenomeno sociale anche solo superficialmente. Così, anche quando è animata da buone intenzioni e umanamente comprensibile, questa enfasi mediatica sembra proprio un capitolo di quel racconto depressogeno che vorrebbe far dipendere il senso della tua vita dal lavoro e dal denaro. A questo punto, se ti trovi nelle condizioni disperate di chi non ha lavoro né denaro, ti rendi conto che smarcarti da questo racconto è una questione di sopravvivenza. Ma tapparti le orecchie per non sentirlo non basta. Devi capire perché è così potente, così pervasivo.
Come ogni narrazione, anche il racconto della crisi ha bisogno di “personaggi”. La “storia” ridotta all’osso, è appunto il racconto delle peripezie del personaggio che ne è protagonista. Ora, quanto più il personaggio incarna un preciso “tipo” umano o un determinato modello antropologico, tanto più assume un valore universale. La forza dell’Odissea, tanto per fare un esempio alto, è certamente nelle avventure del suo protagonista Ulisse, ma anche e soprattutto nel fatto che Ulisse incarna il modello dell’uomo che supera ostacoli e difficoltà sovrumane forte della propria intelligenza. Se le stesse straordinarie vicende fossero capitate a un personaggio diverso, non sarebbero le stesse e non avrebbero lo stesso fascino.
Tornando al racconto della crisi odierna, a quell’idea che lega il senso della nostra vita al lavoro e al denaro, è possibile vedere in filigrana che esso fa appello a due “tipi”, a due modelli antropologici distinti, lontanissimi l’uno dall’altro. Il primo traspare ogni volta che sentiamo ripetere, con la naturalezza di un assioma, che disoccupati, licenziati, cassaintegrati e pensionati poveri, per il fatto di non avere un lavoro o un reddito sufficiente, sono privati della dignità personale e di un posto nella società.
È il modello, che potremmo definire lavorista-emancipatorio, dell’uomo (anche della donna, in realtà, ma il modello punta all’universalità e di questa differenza non dà granché conto) che non possiede nulla se non le proprie energie vitali, e che può liberarsi da una condizione di subalternità grazie al lavoro. È il lavoro (che originariamente era quello degli operai delle fabbriche) a dare dignità, diritti, soggettività politica. È il modello che si è affermato con il marxismo, si è consolidato con le conquiste del movimento operaio e ha contribuito a plasmare le moderne democrazie occidentali. Ma, per quanto positiva sia stata la sua funzione per almeno un secolo, questo modello perde colpi, e non è la crisi attuale a metterlo in discussione. In Italia, sono almeno venticinque anni che il lavoro (divenuto intanto, grazie al boom del dopoguerra, il “posto fisso”) appare sempre più un traguardo irraggiungibile per un numero crescente di donne e uomini che non possiedono nulla. Questa è la realtà dei fatti. Sul piano simbolico, poi, il modello emancipatorio ha perso quello che, nella grande narrazione socialista, era il suo contraltare: la “storia” e, soprattutto, il suo punto d’arrivo. Senza la prospettiva del sol dell’avvenire, il lavoro restituisce soltanto – a chi ce l’ha – un salario sempre più basso, brandelli di welfare e la solita fatica.
Forse è in questa breccia che si è insinuato – ora per scalzarlo, ora per mescolarsi ad esso a dispetto di quanto ci si aspetterebbe in base alle appartenenze di classe – il secondo modello antropologico al quale, implicitamente, si riferisce il racconto della crisi. È quello che potremmo chiamare “edonistico-consumista”: un individuo che trae il proprio valore, il proprio senso di sé, dal denaro che ha e che può spendere, dai beni che può comprare. È il modello introdotto dal boom economico del dopoguerra, che ha trionfato con la società dei consumi e che si è incarnato in tante varianti, da quella glamour del lusso ostentato dai vip a quella da bancarella delle griffes taroccate, passando per le infinite comode rate che una volta o l’altra hanno conquistato chiunque avesse una busta paga.
Un modello che oggi vacilla sotto i colpi della crisi insieme all’esplosione della bolla dei consumi che lo ha accompagnato negli ultimi anni; ma, come un’anima in pena, si insinua nel racconto della crisi perseguitando senza tregua chi oggi non può più permettersi beni che un tempo erano considerati superflui o di lusso e che la bolla consumistica aveva offerto allegramente a tutti: se non puoi cambiare telefonino o fare una vacanza, sei un poveraccio, un fallito, un relitto ai margini della società. Al contrario del modello emancipatorio, quello consumista non fa parte di una grande narrazione collettiva, e non c’è bisogno di essere pericolosi estremisti di sinistra per vedere l’inganno (innanzitutto economico) che nasconde. Se mai ti ha sedotto, quando fai fatica a pagare l’affitto riesci a liberartene abbastanza facilmente. Quello emancipatorio, invece, vorresti tenertelo stretto: nel mondo in cui vivi, il lavoro è la base della tua vita materiale, dei tuoi diritti, della tua indipendenza; l’Italia, dice il primo articolo della Costituzione, è una repubblica fondata sul lavoro.
Il problema è che la crisi ti ha espulso da questo modello, oppure non ti ha mai permesso di entrarci. In ogni caso, non dà conto della tua vita reale, non ti permette di dare un senso al tuo vissuto, non ti offre prospettive. È come usare la foto a grandezza naturale di qualcun altro al posto di uno specchio. Chi subisce la crisi nelle sue forme più estreme ha bisogno di un altro racconto, il suo, con la sua voce e a partire dal suo vissuto.
La questione è politica, naturalmente, e chi politicamente si schiera a fianco di disoccupati, licenziati, cassaintegrati e pensionati poveri, nel frattempo farebbe bene a smettere di ripetere che costoro, per il fatto di non avere un lavoro o un reddito sufficiente, sono privati della dignità personale, di un posto nella società, eccetera. È una litania convincente, lo abbiamo visto, ma il suo potere di seduzione somiglia a quello della fiammella accesa dalla piccola fiammiferaia, in cui si susseguono rassicuranti scene familiari. È una litania che genera solo depressione.
Conosciamo il finale della storia: la piccola fiammiferaia dovrebbe scuotersi, battere i pugni a tutte le porte, rubare del cibo o intrufolarsi in qualche casa; dovrebbe usare con coraggio e intelligenza quel po’ di energia che ha; invece, rapita dalle immagini tremule e illusorie di un passato perduto, muore assiderata.
(Cristina Biasini)